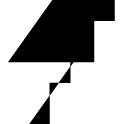architetto

Bernard Rudofsky, allestimento della mostra itinerante Architecture without Architects, 1964. © The Bernard Rudofsky Estate Vienna.
1905 / 1988
Suchdol nad Odrou, Austria - New York, NY, USA
Instancabile viaggiatore, precocemente cosmopolita – quando non occasionalmente apolide – Bernard Rudofsky ha rappresentato, nella relativa indifferenza della critica, uno straordinario vettore di scambio transatlantico, per gli oltre cinquant’anni passati a esplorare, attraverso un’impressionante varietà di forme, lo stesso spazio concettuale. Quello simbolicamente circoscritto dalla sua ultima mostra americana sull’architettura, curata per il Cooper Hewitt Design Museum di New York nel 1980 e basata su uno dei suoi primi articoli italiani, pubblicato su Domus nel 1938, con il titolo programmatico di “Non ci vuole un nuovo modo di costruire, ci vuole un nuovo modo di vivere”; intendendo, con questo termine, la necessità di un nuovo modo di “abitare”. Un tema che, nella sua dimensione multiscalare e interdisciplinare, ha costituito una specie di ossessione per tutta la sua vita professionale, portandolo a occuparsi, con la stessa dedizione iconoclasta, di vestiti e di case come di architetture vernacolari e di urbanistica premoderna. Tutte declinazioni dello stesso modo di stare al mondo, segnato, al di là di ogni limitazione tipologica, dall’interdipendenza di natura e artificio – così come di architettura e vita – di cui aveva rintracciato le radici nel Mediterraneo e nella sua cultura insediativa. E di cui lui, nato austriaco, si è fatto promotore appassionato, con tutte le modalità divulgative possibili, nei confronti di un paese, gli Stati Uniti, segnato da una prima crisi di identità dopo lo sviluppo acritico del Secondo dopoguerra.
Nato in Moravia nel 1905, Rudofsky inizia la propria formazione, nel 1922, nell’ambiente tutt’altro che progressista della Technische Hochschule di Vienna – nelle sue parole “una copia povera dell’École des beaux-arts” – di cui apprezza comunque il rifiuto di un approccio meccanicista al progetto. A essere essenziali per la sua formazione, però, più dei corsi frequentati, sono i viaggi intrapresi in quel periodo. Prima in Germania nel 1923, per vedere la mostra del Bauhaus a Weimar, poi sul Danubio nel 1925, verso Istanbul e l’Asia Minore, attratto da tutto ciò che a molti appare ordinario e anonimo; e ancora in Francia nel 1926, in Italia nel 1927 e, l’anno successivo, a Santorini, dove approda per scrivere la sua tesi di dottorato, alla ricerca di un modo “senza tempo” di costruire e di abitare. La stessa ricerca che, una volta terminati gli studi, nel 1932, lo spinge a stabilirsi a Capri per iniziare la sua pratica professionale in quell’ambiente in cui è sicuro di poterla portare avanti. Qui, infatti, poco tempo dopo il suo arrivo, Rudofsky incontra Luigi Cosenza, che lo invita a collaborare al progetto per il concorso del Palazzo Littorio (1934) e dell’Auditorium di Roma (1935), e con cui inizia a visitare le isole vicine, prima fra tutte Procida, su cui si stabilisce definitivamente per elaborare il progetto di una casa che sintetizzerà tutti contenuti e l’apparato teorico della sua opera successiva. Un progetto che, assieme a quelli – realizzati sempre con Cosenza – per Casa Oro (1934-37) e per una villa a Positano (1936), lo porterà a conoscere prima Giuseppe Pagano, che li pubblicherà tutti su Casabella, e poi Gio Ponti, con cui inizierà una collaborazione sia editoriale – che lo porterà a Milano nel 1937 come collaboratore di Domus – sia professionale, per il progetto di un albergo ad Anacapri (1938).
Sono gli anni di una serie di suoi articoli fondamentali, pubblicati sulla rivista diretta da Ponti, sul senso dell’abitare, sull’abito come prima dimora e sulla casa mediterranea come risposta alle contraddizioni della modernità, nella sua materializzazione di una concezione etimologica di paradiso inteso come stanza a cielo aperto. Ma anche quelli di una sperimentazione progettuale notevole per un architetto della sua età che lo porta a una discreta fama internazionale. Un’esperienza conclusa precocemente nel 1938, quando l’annessione dell’Austria alla Germania nazista lo spinge su un transatlantico per Buenos Aires, per sfuggire al richiamo alle armi. Da qui a San Paolo, quindi, applicando la lezione italiana, Rudofsky realizzerà, nel giro di due anni, quelle che Lisa Ponti riterrà essere “le ville più desiderabili del mondo” – Casa Arnstein e Casa Frontini (1939-41). E successivamente, grazie a un premio assegnato dal Museum of Modern Art di New York, nell’ambito dell’Organic Design in Home Furnishing Competition (1941), avrà modo di trasferirsi negli Stati Uniti, in cui deciderà di stabilirsi definitivamente. Qui, negli anni Quaranta, lavorerà come editorialista per le riviste Pencil Points e Interiors e curerà la sua prima mostra per il MoMA, dal titolo Are Clothes Modern? (1944). Ma soprattutto, progetterà e realizzerà, assieme all’amico Costantino Nivola, la sua straordinaria “casa-giardino” di Long Island (1950), con cui tradurrà, in forma ancora più essenziale e smaterializzata, l’idea di base impostata con il progetto per Procida di un modello dell’abitare ideale.
Nel 1948, però, appena ottenuta la cittadinanza americana – e con essa un passaporto valido – Rudofsky decide di ricominciare a viaggiare, tornando prima in Europa, per poi spostarsi in Messico; coronando, finalmente, il suo sogno di studente di visitare il Giappone – prima nel 1955 e poi nel 1958 – che documenta accuratamente attraverso una serie di reportage su Domus. La tradizione dell’estremo oriente, infatti, è l’unica, secondo lui, a potersi accostare a quella mediterranea nella perfetta unione dei due modi di abitare, quello “spartano” e quello “sibaritico”, la cui armonia sostanzia il principio ideale del vivere; quello, cioè, in equilibrio fra il pensiero magico e quello scientifico, fra sensualità e razionalità, fra natura e artificio. E anche quando tornerà negli Stati Uniti, continuerà, così, a lavorare sul tema tessile approfondito in Giappone, prima per la mostra Textile USA al MoMA (1956) e poi come Chief Architect per l’Expo di Bruxelles (1958). Quando, però, con la fine dei CIAM, avverte che il dibattito culturale globale sull’architettura e sull’abitare inizia a orientarsi su un altro tema – quello dello spazio sociale – anche i suoi interessi prendono una piega diversa. Così, dall’inizio degli anni Sessanta, insieme ad Arthur Drexler, Direttore del Dipartimento di Architettura e Design del MoMA, inizia a pensare a una serie di occasioni divulgative su questo tema, che rappresenterà uno straordinario mezzo di scambio transatlantico.
Sono, d’altronde, gli anni in cui Kevin Lynch pubblica The Image of the City (1960) e Jane Jacobs The Death and Life of Great American Cities (1961); quelli, cioè, in cui studiosi del fatto urbano e progettisti iniziano a interrogarsi sulla strada come spazio sociale e sulla su apparente “morte”, almeno in ambito statunitense. E Rudofsky vuole provare a capire quali siano gli impedimenti strutturali che le città americane oppongono a quel modo di abitare “esteso”, indifferente a confini tipologici e scalari, che aveva conosciuto intimamente nell’area mediterranea e, soprattutto, in Italia. Per questo, con Drexler concepisce una serie di mostre all’interno del International Program of Circulating Exhibition, intitolate Roads (1961), Stairs (1963), Architecture Without Architects (1964) e Streets, Arcades and Galleries (1967) – successivamente cancellata – e pensate come parte di un programma teorico più ampio teso a inquadrare il tema dell’abitare in un’ottica urbana, attraverso il riferimento diretto alla tradizione spontanea e non autoriale del costruire. E se il catalogo della mostra del 1964 ha un immediato riscontro di pubblico e di critica, nel dimostrare le capacità dell’architettura vernacolare di rispondere a problemi senza tempo, il libro costruito con il materiale raccolto per l’ultima, pubblicato con il titolo Streets for People (1969), rappresenterà una sorta di catalogo di riferimenti progettuali di notevole impatto per la cultura disciplinare, che andrà ben oltre i limiti temporali del dibattito contemporaneo.
Gli anni successivi, fino alla sua morte nel 1988, sono, invece, quelli di una sostanziale rielaborazione, fra l’Europa e gli Stati Uniti, degli argomenti già affrontati a proposito del tema dell’abitare, che coprono lo spazio concettuale che unisce il corpo alla città. Argomenti che, dopo la mostra citata al Cooper Hewitt Museum (1980), tornano distillati a Vienna per una mostra al MAK dal titolo Sparta/Sybaris: Keine neue Bauweise, eine neue Lebensweise tut not (1987), proprio come quello del suo articolo scritto nel 1938 per Domus. Una mostra in cui, ancora una volta, Rudofsky ripropone le riflessioni di fondo che sono state al centro della sua ricerca, che ha visto progetto architettonico, editoriale, curatoriale ed esistenziale assumere lo stesso ruolo di divulgazione della sua conoscenza diretta. Quella di un viaggiatore, americano di adozione e italiano di elezione, che ha tentato, per metà della sua vita, di offrire al mondo metropolitano in cui si era trovato a stare un riferimento concreto per un modo di abitare – inteso come fenomeno culturale – che non desse per scontati alcuni paradigmi di sviluppo, ma che si interrogasse sul modo in cui, nella storia dell’umanità, si era realizzato in sostanziale armonia. E che, nel rapporto fra tradizione mediterranea e sua traduzione transatlantica, trovava costante motivo di rinnovamento.
Vettori collegati
Casa a Long Island
Casa
Interiors
rivista
Streets for People: A Primer for Americans
libro
Costantino Nivola
scultore
Domus
rivista
Gio Ponti
Arthur Drexler
curatore
Casabella
Program of International Circulating Exhibitions
programma di mostre itineranti
The Museum of Modern Art
museo
Fonti
Guarneri, Andrea Bocco. Bernard Rudofsky: a Humane Designer. Wien: Springer-Verlag, 2003.
Platzer, Monika. Lessons from Bernard Rudofsky: Life As A Voyage. Basel: Birkhauser Verlag AG., ed. 2007.
Rossi, Ugo. Bernard Rudofsky Architect. Napoli: Clean Edizioni, 2016.